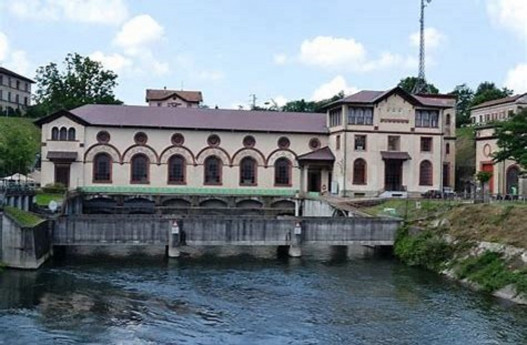Castello Gallarati Scotti
Cozzo fu in epoca romana un'importante stazione per il cambio dei cavalli posta sulla strada imperiale che conduceva verso le Alpi Cozie (da cui deriva il nome della località) ed aveva nel III secolo d.C. la dignità di città municipale cui faceva capo tutto il territorio dell'attuale Lomellina. Con la fine dell'impero romano anche Cozzo conobbe un lungo periodo di decadenza, sino a quando i monaci benedettini di Cluny vi fondarono un'abbazia e iniziarono a bonificare il territorio. Nel medioevo, per la sua posizione in prossimità del corso del Sesia, Cozzo fu dotato di un forte castello, ricostruito dai Milanesi nel 1214 e rifatto nel XV secolo, quando divenne possesso della famiglia Gallarati. Il Castello Gallarati Scotti fu riedificato intorno alla metà del XIV secolo in luogo della precedente costruzione fortificata dell'XI secolo e circondato dai fabbricati dell'antico ricetto. Nel secolo successivo Francesco Sforza conferì il Castello alla famiglia Gallarati, che sopraelevò di un piano l'edificio aggiungendo la merlatura ghibellina e sistemò il torrione d'ingresso con funzione di rivellino. All'interno si conserva il dipinto monocromo di scuola leonardesca raffigurante la celebre "Madonna dell'Umiltà". Un’interessante nota storica: una delle sale ospita una copia di quello straordinario documento che è la Tabula Peuntingeriana, fondamentale per le contemporanee conoscenze sulla geografia del mondo antico. La Tabula, unica rappresentazione cartografica della rete stradale romana che sia giunta sino ai nostri giorni, colloca Cuttiae, Cozzo, come tappa intermedia tra le località di Lomello e Vercelli. La rappresentazione grafica di Cuttiae in questa tavola non si limita alla sola didascalia, ma è arricchita da un’icona, raffigurante due edifici affiancati, che si riferisce di norma alle località più importanti in relazione all’antica viabilità (Mediolanum, Milano per esempio è raffigurata con la stessa icona). I dati presenti nelle fonti scritte vengono confermati da quelli offerti dall’archeologia: da Cozzo proviene infatti una colonna miliaria riprodotta al Museo in dimensioni reali di 1,90 m di altezza e 90 cm di circonferenza, rinvenuta nel 1802 a 2 km da Cozzo che riporta il nome dell’imperatore Antonino Pio seguito dal numerale in cifre latine LVIII, che indicava la distanza tra Cuttiae e Mediolanum, identificata come il “caput viae” della strada che attraversava la Lomellina. La Via Regina è il fil rouge di tutto il racconto del percorso museale allestito all’interno del Castello Gallarati Scotti. I visitatori sono invitati dalle guide del circuito The Original History Walks® che curano l’accoglienza a percorrere le vie del passato, a sovrapporle a quelle del presente per provare ad immaginare insieme un futuro comune più sostenibile. Il Castello Gallarati Scotti è un museo-laboratorio in continua evoluzione e trasformazione. È sede della Bottega di Leonardo, un team di giovani professionisti, dall'ingegnere idraulico al fisico teorico, dagli esperti di musica e interpretariato alla nutrizionista che, in italiano e in inglese, coinvolgeranno gruppi, scolaresche, famiglie invitandoli a tornare più e più volte per percorrere un tratto di strada insieme. Durante tutto il percorso, arricchito da pannelli esplicativi in italiano e inglese, installazioni digitali di realtà aumentata e artificiale, oculus e altri strumenti interattivi ricorderanno come la progettazione del futuro si basi su una profonda consapevolezza e conoscenza del passato. Si potrà, tra le altre installazioni, interagire con un amministratore-avatar, (l’attore pavese Davide Ferrari) che, alla scrivania da cui per secoli sono state gestite le terre di proprietà del castello e le maestranze che qui hanno lavorato, racconterà la via della giusta amministrazione Lo splendido affresco monocromo della Sala del Re che ricorda lo storico incontro nel 1499 a Cozzo del Re di Francia Luigi XII poi prende vita e si anima, grazie alla tecnologia della realtà aumentata, davanti agli occhi dei visitatori proprio nel momento dell’arrivo dei due cortei: da una parte Luigi XII, scortato da alabardieri, in compagnia dei cardinali Giorgio d'Amboise, Giuliano Della Rovere e da un altro un personaggio che si pensa fosse Cesare Borgia. Di fronte la padrona di casa, Maria Percivalle Roero, moglie di Pietro Gallarati, con il marito, le damigelle e giovani cavalieri. È una bellissima istantanea d’epoca in cui la politica del confronto ha il sopravvento su qualsiasi conflitto e prova a ricomporre dissidi che sembrerebbero insanabili. Un messaggio di grande attualità. Pietro Gallarati, primo signore di Cozzo, era proprio questo, un grande diplomatico dalla carriera sfolgorante durata per quasi cinquant’anni. Intimo della famiglia ducale, tanto che Galeazzo Maria, il figlio di Francesco, lo chiamerà sempre zio, riconoscendogli un ruolo di guida autorevole ma affettuosa, è consigliere aulico, cioè di corte già nel 1452, gli sono affidati incarichi diplomatici di grande rilevanza e fiducia presso le corti e i potentati italiani e stranieri, a Venezia, Mantova, Napoli, in Francia, a Roma, nel Monferrato. Partecipa a trattative di pace e concorre a stipulare patti di matrimonio che non sono altro che alleanze politiche, come ad esempio quello tra Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Maria Sforza, futuro erede del ducato che vede Leonardo come organizzatore della Festa del Paradiso. Fu proprio Pietro Gallarati a recarsi a Firenze insieme a Cicco Simonetta, allora proprietario del castello di Sartirana, per convincere Leonardo a spostarsi a Milano alla corte degli Sforza ed iniziare tra l’altro quelle mirabili opere di ingegneria idraulica che hanno trasformato il volto di un territorio e permesso di introdurre quella coltura che da ‘spezia’ diviene un alimento di uso sempre più comune: il riso. Sono tante le sorprese e i motivi di meraviglia all’interno del Castello perché il percorso permette più livelli di approfondimento e fruibilità a seconda degli interessi di chi lo visita. Oltre alla ricerca storica e scientifica puntuale che ha visto il contributo fondamentale delle storiche Maria Luisa Chiappa Mauri e Luciana Fantoni, dell’archeologo Nicola Cassone e del geologo Pier Luigi Vercesi insieme ad Andrea Gallarati Scotti e Silvia Passoni, e alla bellezza dei pezzi esposti, tra cui una sala di mappe del territorio magistralmente restaurate, il museo è arricchito da sale immersive, realtà virtuale e applicazioni di realtà aumentata ideate da 4Draw, studio grafico pavese, uno studio geologico di questa terra particolarissima per fonti, fontanili e risorgive, un plastico ne mostrerà anche la formazione ed un grande video seguirà con un drone il corso del Cavo Gallarati Scotti che per trentun chilometri porta le acque dalla Palude di Vinzaglio fino a Cozzo per irrigarne i campi e renderli pronti a dare vita alla coltura del riso, coltura lomellina per eccellenza fino alla creazione di consorzi, come per esempio il Consorzio Est Sesia, e all’applicazione di un nuovo concetto di agricoltore che diventa imprenditore agricolo in grado amministrare e custodire per un bene comune. Spostandosi attraverso l’allestimento curato dall’architetto Maria Paola Gatti dello Studio Torriani-Gatti di Pavia e dall’architetto Antonio Mazzeri si avrà concretamente la sensazione di percorrere una immaginaria strada che mostra l’unica via possibile per conservare e trasmettere l’eredità di cui siamo chiamati ad essere custodi. Il Castello che possiede un ampio ricetto ed un’aula didattica predisposta all’accoglienza di attività per gruppi, scolaresche e famiglie sarà aperto tutto l’anno solo su prenotazione, orari di apertura e contatti sul sito castellogallaratiscotti.it - info@castellogallaratiscotti.it - +39 340 1480301