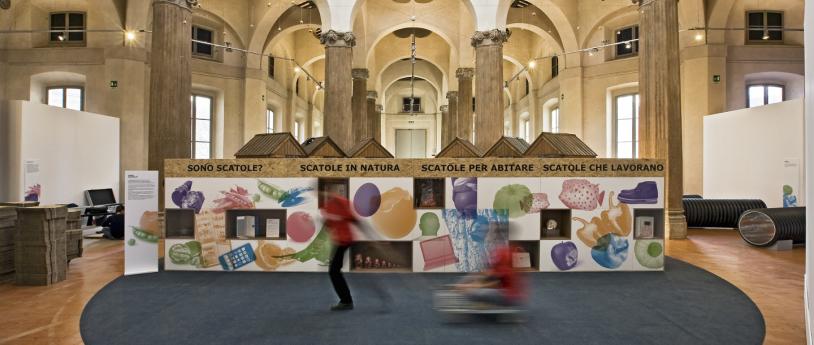Il rinnovamento rinascimentale degli edifici religiosi sul Lago d'Iseo
Il periodo di pace e di discreta prosperità garantito dal passaggio sotto la Repubblica di Venezia (1428) e dalla pace di Lodi (1454), pone le condizioni ideali per avviare un rinnovamento degli edifici religiosi e civili. Varie fabbriche mostrano, tuttavia, come il Rinascimento architettonico e figurativo nel Sebino stenti ad attecchire in maniera nitida e omogenea e vada, al contrario, a mediare con elementi gotici ancora in uso a fine secolo e oltre. Sul piano dell’architettura si assiste a nuove fondazioni e a numerosi casi di ampliamento e aggiornamento di edifici medievali come a Vello, Sant’Antonio di Marasino, San Pietro di Tavernola, Santi Cassiano e Ippolito di Gargarino, San Pietro di Provaglio, San Paolo a Sarnico. Il modello architettonico che si diffonde – se è lecito parlare di modello – non è un’esclusiva del Sebino, ma si riscontra pure in Valle Camonica, in Franciacorta e nelle valli bergamasche. Si tratta di una chiesa a unica navata scandita da archi in muratura su cui poggia la copertura a due falde, spesso con travi a vista, mentre il presbiterio a pianta quadrangolare è coperto a volta; la facciata è decorata dal portale in pietra. Allo schema ‘base’ si possono aggiungere varianti dettate da esigenze strutturali e di spazio (come a Tassano) o dalla disponibilità della committenza. Nella Santa Maria in Silvis e nella vicina Santa Maria della Neve vi è l’aggiunta degli archetti ciechi sottogronda in facciata. Archetti ciechi e finestroni ad arco lobato ribassato sono impiegati pure in Santa Maria in Valvendra a Lovere, edificata a partire dal 1473, anche se le soluzioni architettonico-strutturali qui adottate – in particolare nel presbiterio – rappresentano un unicum sul Sebino, tanto da suggerire l’adozione di un modello proveniente da centri più aggiornati. La cultura lombarda non è comunque l’unica lingua disponibile: sul fianco di Santa Maria in Valvendra – sotto un protiro dalle linee rinascimentali – l’insolito portale a modanature intrecciate è riconducibile a lapicidi di cultura altoatesina. Nei due due comuni a nord del lago (Lovere e Pisogne) emergono le più significative testimonianze, sia pittoriche sia scultoree, della diffusione della cultura antiquaria assai diffusa a Bergamo e a Brescia. Tra i protagonisti è da ricordare la famiglia dei da Cemmo, che negli ultimi due decenni del secolo deteneva una sorta di monopolio dei cantieri in Valle Camonica e opera fino a Bagolino, Brescia e Cremona ma non riesce a farsi strada e si ferma a Pisogne, dove lascia in Santa Maria in Silvis uno dei più significativi cicli pittorici. Nella decorazione della chiesa Giovan Pietro da Cemmo inserisce elementi architettonici e medaglioni con volti di profilo che segnano una decisa adesione ai modelli della cultura antiquaria. Lo stesso vale per i frescanti attivi nel presbiterio di San Pietro a Tavernola, portatori di un linguaggio stilistico-architettonico ispirato a esempi milanesi e bramanteschi. Rientrano in pieno in questo gusto anche i portali in pietra simona realizzati dal milanese Damiano Benzoni, formatosi a Milano presso la bottega di Giovanni Antonio Amadeo, per le chiese di Santa Maria della Neve con profili entro medaglioni inseriti nella decorazione scultorea, e Santa Maria in Silvis a Pisogne e di Santa Maria in Valvendra a Lovere. I due portali pisognesi conservano anche rari esempi di scultura a tutto tondo in pietra bianca. Nei cantieri architettonici spesso gli elementi che attestano il maggior aggiornamento sono proprio i complementi scultorei: i cordoli delle finestre, i portali d’ingresso e i capitelli su cui poggiano le volte. In assenza di tracce documentarie è solo possibile ipotizzare la produzione locale con il supporto di maestranze lombarde. Il rinnovamento della devozione e la diffusione di confraternite sollecita la diffusione di cicli con storie di Cristo e della Vergine. Se nulla è possibile dire del perduto tramezzo dipinto nel convento dell’osservanza francescana a Lovere, sono conservati i cicli di Gandizzano, Pisogne, Solto Collina, Gargarino, Zone (Santi Ippolito e Cassiano) e Provaglio. Un ruolo non secondario è svolto dalle stampe, in particolare quelle raffiguranti la Passione, che sono spesso il veicolo preferito per la circolazione di i modelli iconografici e stilistici d’oltralpe: si vedano a tal proposito le citazioni da Martin Schongauer nel ciclo di Provaglio d’Iseo e da Albrecht Dürer in Santa Maria della Neve a Pisogne. A uno sguardo d’insieme, la situazione artistica appare eterogenea, caratterizzata dalla presenza di una serie di artisti, nella maggior parte dei casi ancora senza un nome certo, di formazione e provenienza diverse anche se con alcuni tratti stilistici comuni. Per la sponda bergamasca pare che la direttrice artistica cui guardare sia la Val Seriana anziché la Valle Camonica. Mentre Giacomo Borlone lavora nell’oratorio del Crocifisso di Solto Collina, uno sfaccettato catalogo di affreschi ancora di dubbia attribuzione è visibile a Parzanica (Santa Trinità), Gargarino (Santi Ippolito e Cassiano) e Zorzino (San Bernardino, affreschi strappati ora in parrocchiale). Sul lago trovano spazio il provagliese Domenico Toselli, operoso in case private e nella chiesa di San Pietro in Lamosa, e il gruppo di pittori – non locali – alle prese con una vasta campagna di affreschi inerenti le Storie di Cristo nella Disciplina di Santa Maria Maddalena a Provaglio. Ignoto è l’autore della Pietà con i santi Cosma e Damiano (ultimo quarto del XV secolo) in San Paolo a Sarnico. Affascinanti per la diversa estrazione sono i frescanti che per più di un secolo si alternano nella chiesa di San Pietro in Lamosa e le maestranze che hanno realizzato gli ex voto in Santa Maria del Mercato a Iseo. Un unicum risulta per ora sul territorio del lago la decorazione della cappella di San Pietro a Lovere (1493/94) che testimonia la presenza di un maestro altoatesino a riprova che il Sebino fu luogo di passaggio per varie maestranze. Questa varietà di orientamenti caratterizza ancora il primo quarto del XVI secolo. A cavallo dei secoli XV e XVI la bottega detta del Maestro dei Santi Ippolito e Cassiano (per il ciclo realizzato nell’omonima chiesa a Zone) propone sul Sebino (a Gandizzano, Marasino, Santa Eufemia di Nigoline) schemi piuttosto impacciati e attardati, ma che godono di un certo favore presso la committenza. Contemporaneamente, è documentata sul lago la presenza di artisti più aggiornati sulle novità elaborate nei principali centri lombardi. In Santa Maria in Valvendra a Lovere si susseguono gli interventi del bresciano Floriano Ferramola, (1514) e di Andrea da Manerbio (1535) nelle cappelle dell’Immacolata e di San Giuseppe. Capolavoro assoluto del Rinascimento sono le ante d’organo della chiesa dipinte da Ferramola e da Moretto, commissionate però nel 1515 per il Duomo Vecchio di Brescia e trasportate a Lovere solo nel XVIII secolo. Tra primo e secondo decennio approda sul lago il notevole autore della decorazione dell’oratorio di San Rocco a Peschiera, da alcuni identificato con lo stesso Romanino. Quest’ultimo interviene a Tavernola. Proprio il caso di Santa Maria della Neve a Pisogne, successiva tappa del pittore, consente di leggere le dinamiche del ‘rinnovamento’ culturale. La chiesa era stata decorata forse sul finire del secolo dai da Cemmo (restano, di questo intervento, alcune sinopie nel presbiterio e la decorazione della cappella esterna). Dopo neppure mezzo secolo, l’intera decorazione fu sacrificata a favore di un nuovo ciclo commissionato a Romanino. Sul fronte opposto si schiera l’ignoto frescante che nel 1539 realizza mediante un linguaggio assai attardato il ciclo della Passione della chiesa di Gandizzano ispirandosi ai nobili modelli romaniniani. Federico Troletti